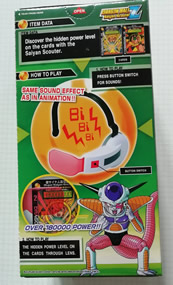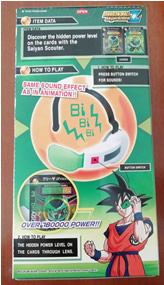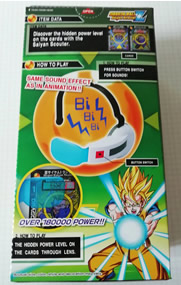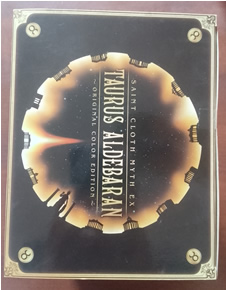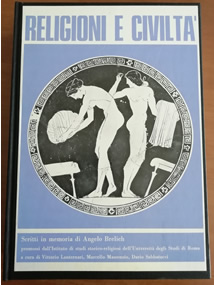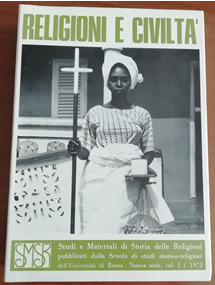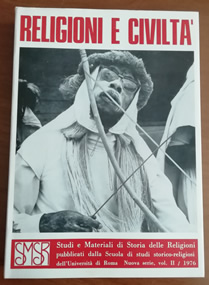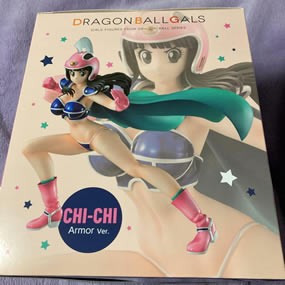Para una reconsideración de nuestras alianzas y bajarse del carro llamado âOccidenteâ.
Carlos X. Blanco
Nos encaminamos hacia un mundo hobbesiano. Si no hay reglas, y ni siquiera hay hipocresÃa hacia las reglas (que es el último tributo rendido a la norma violada, la cual se la reconoce a la vez que de ella se burla), entonces la fuerza bruta en las relaciones internacionales es lo que prevalece.
Sin embargo, incluso el recurso a la fuerza bruta por parte de los Estados Unidos, después de 80 años de hipócrita perorata y de âeducación para la pazâ puede ser sÃmbolo y máscara de muchas otras cosas. Donald Trump empleó la fuerza bruta hace escasos dÃas, secuestrando al Presidente de una nación soberana y bombardeando la capital y otras zonas de un paÃs formalmente libre; esta vez le tocó a Venezuela. Un paÃs soberano ha sido agredido salvajemente por otro, a los ojos de todos. El hecho no es nada nuevo en la historia de los Estados Unidos. Desde que existe el paÃs de las barras y las estrellas, la violencia, el genocidio, la injerencia, la invasión, etc. han sido parte de sutónica habitual. Donald Trump no es ninguna excepción en la historia de este imperio de pesadilla, que es el imperio de los Estados Unidos.
Los modales de Trump pueden parecer más zafios que los de otros presidentes, pero esta no es la cuestión decisiva. La cuestión que nos debe (pre)ocupar es otra: los actos mismos, en qué coyuntura se realizan, qué se persigue con ellos, qué se quiere anunciar y esconder con todas estas acciones violentas y brutales. De ahà que la agresión a Venezuela y el secuestro de Maduro y su señora sean sÃmbolo y máscara de otras cosas, además de actos violentos e ilegales en sà mismos.
Los más simplistas se quedan con la simple idea de la acción violenta en sÃ: nos conmociona esa naturaleza violenta e ilegal de lo sucedido el 3 de enero en Caracas. Asà se queda una parte de la humanidad, recurriendo a la ciencia del Derecho y a la ciencia de la PsicologÃa. En estado de schock, mezclado una inmediata sensación de fatalismo. Nada se puede hacer. Sin el contrapeso de la URSS, el hegemón no es contestado, al menos en el patio que él domina, en la parte trasera de su casa.
Si no es el derecho y la psicologÃa, otros meriendan lecciones de Ãtica. Más simplistas me parecen los âopinantesâ que, armados con nuestro habitual manual occidental de moralina, ora izquierdista ora derechista, condenan o censuran lo acaecido. Jueces morales de a pie, carentes de toga, salen en los medios y redes, a millones: Maduro es un dictador, un narco, se lo ha buscado (ala derechista de los adoctrinados). Trump es un matón, un sheriff, un fascista (ala izquierdista de los adoctrinados).
La hemiplejia ideológica, de la que certeramente habló Ortega, se pone en seguida en acción: nos volvemos un poco imbéciles, decÃa el filósofo madrileño, sintonizando siempre con nuestra propia configuración ideológica, centrándonos en la propia âzona de confortâ, evitando nuestras disonancias cognitivas. Lo mismo hemos vivido, con sandez incorregible, en otras coyunturas. Por lo visto, el genocidio de la Entidad Sionista contra el pueblo palestino sólo debe ser condenado por las izquierdas. Todo derechista cabal debe apoyar a los sionistas sin fisuras. Posturas análogas en el tema de Ucrania las seguimos observando desde la âinvasiónâ: en este caso los ârusófilosâ son de âextremaâ (extrema derecha, extrema izquierda), y los âcentradosâ son demócratas liberales a carta cabal, que defienden la Libertad con los misiles âpatriotâ, los famosos âLeopardâ y toda la demás chatarra que envÃa la OTAN al frente del Este.
Hay que huir de esa extrema sandez. Hay que ser âextremistaâ (de izquierda o de derecha, que esto ya da igual) si en el medio de este mundo se halla el engaño, la vil mentira, la confusión mental. Extremistas en el buen sentido, porque lejos de los extremos ya no reside la virtud, como decÃa Aristóteles. Reside el engaño y la vileza.
El ataque a Venezuela es signo indudable de que el petróleo debe estar asegurado para el Imperio. Signo expreso de que el petróleo y otros recursos básicos para el mantenimiento del Imperio son cosas que deben pagarse en dólares. Con dólares âobligatoriosâ, el vampiro yanqui se mantiene con vida, alivia su agujero negro de deuda. En dólares el TÃo Sam mantiene una tiranÃa económica en todo punto complementaria de su tiranÃa mundial ejercida por medio de las armas. Los vasos comunicantes entre ambas formas de tiranÃa son conocidos. El ataque a Venezuela es signo de poder, pero máscara de una debilidad de fondo. Voy a explicarlo.
Dólares y cañonazos. Son dos caras de la misma moneda. El caso es que algunos de esos vasos comunicantes entre un saqueo económico sistemático a la humanidad y una amenaza armada, violenta (acaso desde la gran crisis financiera de 2008) se están cortando. La bestia está herida y dará zarpazos, pero la coherencia de sus armas de dominación se está quebrando.
El ejército yanqui se está mostrando disfuncional, pese a su enorme volumen, omnipresencia y gran capacidad ofensiva. Los costes de su tela araña tendida sobre el mundo se van disparando. La escalada de los oponentes (rusos, chinos, acaso en un futuro indios o brasileños, por ejemplo) será ruinosa para el yanqui. Los rivales invierte, el yanqui gasta. La renovación tecnológica de muchos componentes se hace imposible si para ella no se cuenta, paradójicamente, con el âenemigoâ (los chinos, sustancialmente). Nadie puede atacar a un enemigo al que le tienes que comprar elementos clave para sostener ese ataque. El valor y la eficacia de las tropas, por otro lado, más allá de las muy hollywoodienses unidades de élite, es muy cuestionable: Vietnam, Iraq, Afaganistán⦠los norteamericanos son expertos en destrozar paÃses pero incapaces de ganar correctamente una guerra convencional. No es un ejército glorioso. Siempre han fabricado guerras que podÃan ganar injustamenteâ¦hasta que los cálculos fallan. La guerra diseñada con cálculo económico es, de entrada, una mala guerra desde el punto de vista esencial (no solo técnico), pues el dinero sólo es un instrumento para el poder. Nunca puede ser el objetivo. Las guerras hechas para mantener y aumentar el poder deben planearse sin criterios economicistas.
El Imperio endeudado hasta las orejas recurre a la fuerza para mantener sus garras sobre el globo, asegurándose el hemisferio de Occidente y tomando aliento para el futuro asalto a Orienteâ¦pero ¿es esto exactamente asÃ? ¿Estamos seguros?
Analistas muy brillantes, como Alessandro Visalli, sostienen que Trump, volcánico e impredecible como parece ser, posee no obstante una doctrina. Hacia dentro, una Doctrina Monroe brutal: los americanos WASP y âpata negraâ se regenerarán con una moral sexual adecuada, polÃticas natalistas, familias sanas y Biblia (evangélica) en la escuela, en los despachos, en la sopa. En cÃrculos exteriores a su cinturón bÃblico-talmúdico, por el contrario, la doctrina Trump predica el más puro colonialismo directo y feroz (doctrina Monroe para el resto de América, vasallaje y amortización para Europa, aunque quizá con un poco más de consideración hacia los socios de la Anglosfera).
Otros analistas, no menos brillantes, como Pepe Escobar, ven las cosas de una manera que me parece divergente, pero no necesariamente contradictoria: la multipolaridad es un hecho irreversible, el león rugiente trumpiano es la solución cesarista para salvar los trastos y la continuidad de una estructura inmensa que se derrumba.
En efecto, se suele decir que la fiera herida es la más peligrosa. La caÃda de este Imperio aboca a escenarios temibles, uno de ellos es la catástrofe de una guerra nuclear que, aun concentrada en Europa -¡pobres de nosotros!- llegarÃa a tener un alcance necesariamente mundial. Otro diverso, muy mortÃfero también, es el escenario de la agravación de guerras regionales y conflictos de diversa escala, conflictos que se irÃan intercomunicando hasta hacer del globo un campo de batalla enorme, con zonas rojas que sucesivamente, pero no todas a la vez, se irÃan encendiendo. Hay posibilidades para un escenario âoptimistaâ, siguiendo a Escobar, que es el del triunfo de la multipolaridad, es decir el auge de los BRICS (liderados por China y Rusia) y la caÃda concomitante del Imperio yanqui por puro desgaste e insostenibilidad del mismo.
Nuestro análisis deberÃa ser todo, menos âhemipléjicoâ y siempre muy realista. El realismo en polÃtica, relaciones internacionales, geoestrategia, etc. no sabe nada de izquierdas ni de derechas. No conoce âa priori- filias ni fobias. El realismo obliga a detectar quién âde entre los agentes- posee un mayor quantum de poder, y cuál de los actores estratégicos posee capacidad. Los agentes no son sólo Estados, pues también han cobrado protagonismo en las recientes décadas los entes financieros, fundaciones, entes multinacionales, aunque todos ellos actúan siempre coordinados con los Estados, que son los que poseen ejércitos.
Se es capaz en términos de poder, en un escenario dado, o no se es capaz, de confrontar otro quantum de poder al ente hegemónico. Inspirándome en la teorÃa de Gianfranco La Grassa, conocida con el nombre de TeorÃa del Conflicto Estratégico, creo que en realidad se abre, con este atentado contra Venezuela, un terrible escenario mundial policéntrico, más que multipolar. El policentrismo, a la manera de las luchas feudales medievales y de las ficciones hobbesianas, consiste en una lucha de todos contra (casi) todos, pugna desplegada con enormes desgastes y erosiones de los agentes hegemónicos tradicionales. El viejo orden se resiste a morir, y el nuevo orden no surge todavÃa.
Los Estados Unidos se enfrentarán a victorias pÃrricas. Se me viene a la mente la victoria pÃrrica de España sobre Napoleón: España devino una potencia erosionada hasta el lÃmite, desgarrada bajo el modo âguerra civilâ para todo el siglo XIX y XX, una potencia convertida en despojo para los europeos, especialmente los anglos. Es un caso de libro: estar en el bando formal de los vencedores, pero condenada a ser un eunuco y una ruina para beneficio de todos los demás. Es ganar perdiendo.
El imperio británico también fue un agente estratégico pÃrrico en 1945, si bien conservó un aguijón, el MI6, y sobrevivió como entidad secundaria y provincial del hegemón yanqui. El Reino Unido actual va camino de ser, a nivel popular, una parte del Islam, mientras que en el terreno geopolÃtico y económico sigue siendo un perro de presa con el collar puesto por los norteamericanos. DiscÃpulos de Pirro.
El agente o unidad estratégica que es Alemania va camino de lograr su reafirmación pÃrrica sobre Europa: como potencia delegada de los norteamericanos, el gobierno y el complejo militar-industrial germanos cumplirán perfectamente sus funciones de destrucción y endurecimiento represivo de Europa. Alemania cumple hoy su papel subalterno del Imperio, hasta el final. Es el esclavo que azuza con el látigo a los demás esclavos. No puede haber un personaje más despreciable.. Todos conocemos la figura del prisionero de campo de concentración que hacÃa las veces de guardián o vigilante al servicio de las SS⦠sin dejar de ser un maldito prisionero. Eso es Alemania hoy.
No sólo van a arrasar Europa, también sembrarán sal en su tierra. Alemania es un agente subalterno de los yanquis, ejecutor ideal (masoquista) del programa âvasallaje por amortizaciónâ. Trump no quiere aliados, sólo siervos de usar y tirar. Europa âkleenexâ.
Discreta y gradualmente, hay que reconsiderar la polÃtica de alianzas. Si España no lo hace en la siguiente década, desaparecerá. MarroquÃs y judÃos vuelven a pactar en nuestro flanco sur. Una España âoccidentalâ es una España con bases estadounidenses dentro, con una soberanÃa cedida, metiendo en casa, como hizo en su dÃa Franco, al mayor agresor de la Historia. Una España âoccidentalâ es un Estado integrado en ese fracaso, cada vez más parecido a una organización terrorista, llamado OTAN, entidad dispuesta a fundirse con la Unión Europea. Millones de españolitos dijeron sà a la OTAN creyendo que de esta manera los americanos, franceses, alemanes, etc. nos iban a repartir caramelos gratis hasta el fin de nuestros dÃas. El dÃa en que exista un pueblo español salido de la Infancia, ese pueblo querrá irse corriendo de la OTAN. Y, para rematar, una España âoccidentalâ que insiste en ser tan occidental como los marroquÃes y los judÃos, pueblos y estados que deben ser algo asà como el epÃtome de los Derechos Humanos y de las tradiciones europeas⦠Una España que organiza programas âErasmusâ para uniformados en las cercanÃas de Rusia, pero persiste en airear su culo en Canarias y Sur peninsular. Algo más que un constipado es lo que esta patria nuestra va a recibir de tan occidentales aliados por sus partes traseras. No hay muerte más merecida que la de aquel que ni quiere saber quién es
el verdadero enemigo.
a cura di G. P.